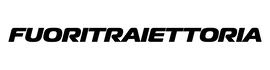Gli ignoranti disprezzano il mondo delle corse sugli ovali. Le prove che adducono a loro favore sono fragili e prive di senso, e spesso dimostrano quanto poco conoscano una delle discipline più affascinanti del mondo automobilistico. Non si tratta di «non sapere girare a destra» come dicono quelli che trasformano la battuta in una chiave per interpretare l’America. È molto di più. Proviamo a capire come stanno le cose (e perché, ogni tanto, gli europei vanno forte anche se debuttanti).

Premessa: gli ovali non sono tutti uguali. Potrà sembrare strano a chi ritiene che poco cambia tra un circuito in cui tutte le curve sono a sinistra e un altro in cui tutte le curve sono a sinistra. Ma dopotutto, sia a Spa sia a Montecarlo ci sono sia curve a sinistra sia curve a destra, e tra l’altro in entrambe le piste ci sono curve percorse a più di 200 km/h (parlo di quella sotto il Tunnel).
Un primo dato da tenere in considerazione è la lunghezza. In genere si parla di ovali corti e ovali lunghi, anche se esisterebbe anche la categoria ibrida degli ovali medi. Il discrimine parla di una lunghezza dai tre quarti di miglio al miglio tondo per gli ovali corti (cioè tra gli 1,2 e gli 1,6km), e attorno alle 2 miglia per i lunghi (Indianapolis è 2,5 miglia, cioè 4 km). Gli speedway (ovvero gli ovali medi) in genere contano 1,5 miglia.
La lunghezza influenza l’assetto delle monoposto, le traiettorie disponibili e soprattutto l’andamento delle corse. Questo perché si combina con il secondo fattore fondamentale: il banking. Cioè quanto le curve sono inclinate. In più, anche la disposizione delle curve può influire (Pocono è un tri-ovale, una sorta di triangolo).

In genere gli ovali corti hanno un banking basso e curve molto ampie: il che significa accelerazione laterale (anche superiore ai 4G), molto tempo percorso in curva e alte velocità. Le macchine hanno bisogno di carico aerodinamico per reggere a questo stress: è la ragione per cui quest’anno Honda ha parecchie difficoltà su circuiti di questo tipo. Il pacchetto aerodinamico della IndyCar per ovali corti quest’anno è lo stesso degli stradali, e la Honda, che paga soprattutto in termini telaistici il gap con Chevy, ha preso botte da orbi su queste piste. Un esempio è Phoenix, in cui ha dominato il Team Penske. Il circuito è lungo 1,022 miglia e il giro più veloce si è avuto al di sotto dei 20 secondi (19”7446 per l’esattezza). Il risultato è che sugli ovali corti ci sono spesso diverse traiettorie percorribili e le corse diventano stressanti perché si crea traffico in brevissimo tempo. Troppa gente in pista pone una pressione immensa sui piloti, e giri tanto corti aggiungono difficoltà nella scelta delle strategie, perché un pit-stop in più o in meno spesso significa la vittoria.
Gli ovali lunghi invece raggiungono velocità impressionanti e hanno banking più basso. Questi superspeedway sono Indianapolis, Pocono, il Texas Motor Speedway: si raggiungono medie molto alte e chiedono basso carico aerodinamico. Ma Indianapolis, per esempio, consente una sola traiettoria ideale e le gare di gruppo diventano più difficili. Un altro inconveniente è che alzare il piede, con così poco carico e velocità tanto alte, spesso non rallenta l’automobile. E frenare diventa sempre un rischio, perché può sbilanciare la macchina, sparata a oltre 300kmh su una pista inclinata.

Al di là del fattore fortuna implicito nelle cautions (ogni bandiera gialla butta in pista la pace-car e chiude la pit-lane, il che a volte stravolge le corse e azzera il lavoro delle lepri di turno), gli ovali hanno una caratteristica. Gli spotter. Sono gli «angeli custodi» dei piloti: li seguono appostandosi in alto, in modo da potere avere sempre sott’occhio il proprio corridore (ogni macchine ne ha uno), e sono in collegamento radio no-stop per segnalare in ogni istante la presenza di altre vetture. Su un tipo di pista in cui si sfreccia a oltre 350 all’ora e bisogna prendere decisioni nel giro di un decimo di secondo, accorgersi dei rivali diventa materialmente più difficile (anche per la larghezza delle vetture). Ma errori di un centimetro possono tramutarsi in tragedia. E con semplici «Stay low!» («rimani basso», cioè mantieni l’interno, perché “su” c’è un altro) ogni spotter risparmia al suo pupillo una buona dose di tragedie.
Lo stile di guida sugli ovali è quindi molto complesso. Chiede ai piloti una grande concentrazione, prolungata e ferrea, e anche un coraggio non indifferente perché tenere giù il piede a certe velocità è innaturale. Bisogna saper reagire in fretta non soltanto ai comandi degli spotter, ma anche alle situazioni in pista, che spesso sono molto più veloci della lingua dell’aiutante. Schivare un incidente è complicato (tenere il piede in mezzo al fumo ha bisogno di fegato).

Anche la regolazione della macchina è peculiare. L’assetto aerodinamico è ovviamente asimmetrico (l’avete detto voi: tutte le curve sono a sinistra) e anche la costruzione del telaio e delle gomme è asimmetrica, con gli pneumatici destri più larghi. Per tacere della doppia versione della DW12, che Dallara ha realizzato in variante stradale (più corta e maneggevole) e ovale (più lunga, per assicurare maggiore stabilità). Ma l’organizzazione delle squadre americane è diversa da quella delle europee: tutti i dati di ogni vettura – e possono anche essere quattro o cinque per team, a Indianapolis – vengono condivisi e discussi dalla squadra nel suo complesso, e utilizzati per i settaggi di tutte le altre. I motori di una vettura per ovali sono progettati per reggere sforzi che apparirebbero disumani a una F1: devono rimanere a pieni giri, nelle marce alte, per ore e ore (Indy dura oltre 180 minuti). La mancanza di decelerazioni e riprese sarebbe fatale a un V8 F1. Non significa che siano macchine migliori (anzi, nessuno nega la superiorità tecnologica della categoria regina europea) ma spiega quanto diverse – e incompatibili – siano le due filosofie di corse. Il che impedisce (purtroppo) che vetture della massima serie possano un giorno prendere lo start della 500 Indy (come accadeva in passato).
Per concludere, qualche parola sui piloti europei e americani. Nel Vecchio Continente circola la favola che un qualsiasi pilota europeo si berrebbe la griglia della IndyCar. La vittoria di Alexander Rossi sembra suffragare questa ipotesi, ma non è così: il #98 di Andretti ha corso solo con la Marussia in F1, non mettendo a nudo tutto il potenziale. E comunque in America nessuno lo crede un asso della serie solo per la vittoria di Rossi a Indy 2016: dopotutto, vinse perché risparmiò qualche bicchiere di etanolo in più dei piloti di testa, risparmiandosi l’ultimo pit-stop. Non proprio una dimostrazione di forza. È vero che adesso sta acquistando competitività e rispetto. Ma soltanto adesso.

In più nella IndyCar corre anche Max Chilton, per il Ganassi Racing. Anche lui corse per la Marussia, e sta faticando come un matto per garantirsi il rinnovo. Luca Filippi, indiscutibilmente il miglior pilota italiano dei primi anni Dieci (anche più di Valsecchi), ha corso qualche gara ma è stato scartato. Stefano Coletti, nonostante la grande esperienza, ha concluso una stagione e non è mai riuscito a riavere il sedile. Takuma Sato ha vinto la Indy 2017: ma a parte questo, il suo sedile è garantito soltanto dalla motorizzazione Honda, nonostante diverse vittorie.
Ci sono i precedenti di Mansell e Fittipaldi. In effetti, John Surtees ha vinto F1 e Motomondiale, ma nessuno si sogna di dire che Valentino Rossi farebbe meglio di Vettel con la SF70H. Forse perché le categorie sono troppo diverse (e i precedenti troppo distanti) per trarre da un singolo caso una regola generale? Dopotutto, ci sarebbe perfino la controprova: anche Nuvolari era meglio su quattro ruote che su due…

Prendiamo, infine, il caso Alonso. Quali sono le sue virtù? Mentalità da gara (indispensabile, su 800km). Concentrazione ferrea (indispensabile, su un ovale). Coraggio e tenacia (vedi sopra). Ha corso con Andretti, team storico, motorizzato Honda, il miglior motore sui superspeedway, assistito da McLaren (avete bisogno di presentazioni?). Ha condotto le fasi centrali della gara (importanti, certo, ma non indicative quanto gli ultimi 50 giri, in cui tutti tirano fuori le carte che hanno). Non dico che fosse lecito aspettarsi questo risultato – non me l’aspettavo nemmeno io – ma da un grande campione, è davvero motivo di somma meraviglia? Se non ci sono i campioni, davanti, una serie è davvero credibile? È davvero competitiva e degna di rispetto?
E in secundis, messo su una delle migliori macchine del lotto, anche Hamilton ha vinto al debutto. Vettel ha vinto nel 2008, quasi esordiente, con la Toro Rosso (e poi ha battuto record di gioventù incrollabili). La prima corsa di Perez in F1 lo vide capace del miracolo di fermarsi ai box una sola volta anziché due o tre come gli altri. Verstappen è più giovane di me.
Bisognerebbe sconfessare la diceria che i piloti americani fanno schifo in Europa, ma è piuttosto difficile. Tralasciando la striscia di piazzamenti positivi di conduttori cresciuti negli States riportati alle 24 ore di Le Mans (sappiamo che gli ignoranti conoscono solo la F1), ci sono pochi precedenti di campioni IndyCar transitati in Formula Uno. Dico campioni della serie, anziché vincitori della 500 miglia, perché a Indianapolis è difficile che vinca gente come Rossi, ma non impossibile. Uno di questi è tirato in ballo tutte le volte che si parla della questione: Sebastien Bourdais, tetra-campione ChampCar, sverniciato da Vettel in Toro Rosso.

Da Vettel. In Toro Rosso. È pacifico che passare da una macchina migliore a una peggiore crea problemi (come dimostra la stagione 2014 dello stesso Vettel). È pacifico anche che il passaggio opposto crea faville (come dimostrano le stagioni 2014 di Ricciardo e 2016 di Verstappen). È infine pacifico che avere un pilota che fa un passaggio e un altro che fa il passaggio opposto crea un certo divario. Aggiungiamoci il cambio di serie. Aggiungiamoci l’indiscutibile talento di Sebastian, e infine aggiungiamoci che i quattro titoli di Bourdais non sono proprio “quattro”: nell’automobilismo i titoli si pesano e non si contano, dice qualcuno. E Bourdais vinse quando le IndyCar erano divise tra la ChampCar e le IRL: la griglia (e la competitività) era ridotta.
Insomma, Bourdais-sverniciato-da-Vettel non è un precedente molto indicativo. E mi permetto di obiettare che Jacques Villeneuve ha vinto prima in America e poi in Europa. Non è indicativo nemmeno lui, perché si è formato in Europa? A dire il vero, si è formato anche in Giappone (dove corse Ralf Schumacher – Ralf, attenzione, Ralf), poi nell’americanissima F5000. E in ogni caso, anche se Villeneuve fosse cresciuto sportivamente in Europa, oggigiorno tutti i piloti americani si formano in Europa. Compreso il debuttante, scarso, stupido vincitore della 500 Indy 2016, Alexander Rossi.