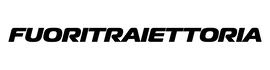Immaginate un anello in cui sfrecciano lampi colorati a 350 chilometri orari. Trentatré schegge dei colori più svariati, che bucano l’aria a velocità folli e macinano l’asfalto così a lungo da rendere l’anello incandescente. Lì correrà Fernando Alonso.
La 500 miglia di Indianapolis è sempre stata una corsa per pazzi sconsiderati. Da decenni è uno dei circuiti a percorrenza media più alta del mondo. Ci sono quattro curve in tutto, tutte e quattro a sinistra. E siccome altrimenti andrebbero troppo piano, sono soprelevate e con un’inclinazione di 9°12’.
A fine maggio si corre (fin dal 1911) una gara della durata di oltre 800 chilometri. «La più lunga delle gare sprint e la più corta delle gare endurance» la definì Michael Andretti, il figlio di Mario. Un bel problema: come si affronta una gara del genere? Be’, chi ci volesse provare, deve tenere presente un punto: la chiave è nelle ultime 100 miglia.
Il che spiega la difficoltà. La 500 Indy è una gara tosta, signori. Non è facile mantenere la calma e la concentrazione per oltre due ore e mezzo, capaci di dare il massimo proprio negli ultimi metri, sempre pronti a lasciare l’acceleratore quando escono le bandiere gialle, attentissimi a schivare detriti e automobili impazzite che prima si spalmano contro i muretti e poi scivolano nel mezzo della pista perdendo pezzi. Indy ha smesso di chiedere sangue, ma continua a infortunare piloti che è una bellezza. Chiedete a Hinchcliffe e Aleshin.

Ma Fernando Alonso è uno dei piloti più fisici del motorsport. Il suo allenamento è serrato, passa con facilità estrema da una disciplina all’altra. Pur di avere il corpo al 100%, l’asturiano è capace di sforzi sovrumani. E quando è stato in Ferrari (l’ultima monoposto degna di questo nome che ha guidato) lo mostrava a ogni gara. No, i 200 giri a Indianapolis saranno anche una sfida, ma non è la più grande.
È capace di mantenere la lucidità, prima delle energie, fino all’ultima tornata? Sì, è senz’altro possibile. Lo spagnolo voleva correre la 24 ore di Le Mans, può correre anche la 500 miglia. Il vero problema è: avrà il sangue freddo che serve per bersi la bottiglia di latte sul podio americano? Perché questo è il vero problema degli ovali.
Luca Filippi ne parlava qualche mese fa in cabina di commento. «La velocità fa paura» ha raccontato, divertito ma non troppo. Ringraziamo che qualche pace car ha abbassato la media dell’anno passato a circa 268km/h. Ma la pole position marchiò a fuoco la cifra record di 372 chilometri all’ora. Che non è tanto più rapido di un giro normale nel catino dell’Indiana.
Le IndyCar non hanno servosterzo, e stare tanti giri sull’ovale intorpidisce le dita. «Avevo difficoltà a stringere la forchetta a cena» ammise Luca Filippi ai microfoni di Sky Sport. E non parlava della cena di Indianapolis. Parlava del post-gara di qualche altra gara ovale. 500km più corta.

E non basta la freddezza, l’energia e la lucidità per vincere la 500 miglia più famosa del mondo. Tagliare per primo la Brickyard non è possibile, se non si è capaci di reagire alle mosse ai limiti della follia che i piloti della IndyCar tirano in ogni istante. Un pilota europeo fatica a inserirsi nell’ambiente, se non dopo anni. Ma a lungo termine, chi si è fatto le ossa nel Vecchio Continente riesce a combinare l’alta preparazione tecnica delle formule FIA con l’istinto del pistolero richiesto a ogni pilota americano. E a vincere. Basta scorrere la lista (e i curriculum) della griglia: Alexander Rossi, Max Chilton, Simon Pagenaud, Sebastien Bourdais… tutti nomi che hanno studiato qui da noi. Ma che hanno avuto stagioni intere per perfezionarsi laggiù, al di là dell’Atlantico.
Va detto, però, che Indianapolis non è un ovale tra i più difficili. È la lunghezza della corsa, l’enorme pressione mediatica, lo spropositato numero di concorrenti (33 per tradizione, oltre dieci in più rispetto a un qualsiasi GP di F1 o della stessa IndyCar) a complicare le cose. Per esercitarsi in vista della gara più pazza del globo, gli americani sono benevoli e concedono diversi giorni di test speciali ai debuttanti. Lo chiamano Rookie Orientation Program. Ma basterà?
45 giorni alla grande sfida. Lo ha detto lui stesso. «Non conosco nulla della tecnica di pilotaggio sugli ovali. Non conosco nulla delle strategie di gara, dei pit-stop, delle ripartenze». Già. Poco dell’arte della scia, in cui si consumano gomme e si risparmia benzina. Poco degli splash, rifornimenti lampo quando al serbatoio mancano all’appello pochi, ma indispensabili litri di etanolo. E poco anche dell’estrema bagarre della ripartenza, in cui il gruppo si scompone e inizia a schiumare dalla bocca non appena vede la bandiera verde. «Devo capire tante cose, e velocemente, in poche settimane». Uh, in bocca al lupo.
«Ma l’anno scorso la gara è stata vinta da un rookie». Allora non è vero che non sa nulla! E ha perfettamente ragione. Alexander Rossi ha fatto una gara in sordina e ha poi trionfato bevendo il latte del vincitore (che a Indianapolis – e solo a Indianapolis – sostituisce lo champagne). Alonso ha chances di vincere? Che domande! È uno dei piloti più forti della F1: certo che ha delle chances.

Le carte che ha in mano non sono delle migliori. Poteva prepararsi prima, azzardare un test sugli ovali nell’inverno pieno (quando i climi americani permettono quello che il circuito di Barcellona non garantirebbe nemmeno a febbraio). In più, la sua vettura sarà preparata dall’Andretti Autosport. Non è un team stupido, ma è il primo degli ultimi. Dietro i due top team – Penske e Ganassi – c’è l’Andretti, che porta con sé un bagaglio di tecnici e di esperienze davvero ragguardevole. Ha portato a casa 4 titoli IndyCar (l’ultimo nel 2012 con Ryan Hunter-Reay, che corre ancora), in bacheca ha quello vinto da Jacques Villeneuve in CART nel 1995. Sul catino dell’Indiana conta all’attivo cinque successi, compreso l’ultimo di Rossi (2016), quello di Hunter-Reay (2014) e la lontana affermazione di Jacques Villeneuve (sempre nel 1995).
Peccato che l’Andretti navighi a vista. È una scuderia professionale ma con una line-up non all’altezza della situazione. I tecnici sono bravi, ma non abbastanza. E appena Chip Ganassi è ritornato alla corte della Honda, il suo team è diventato capofila della filiera giapponese a stelle e strisce. E allora perché Alonso e la McLaren non corrono con Ganassi? Perché Michael Andretti ha una grande passione: schierare quante più vetture può alla 500 miglia. E quest’anno ne porta sei.
Che la Honda abbia convinto Alonso a correre in America non deve stupire. Mentre in F1 arranca e ha il fiatone, negli Stati Uniti il motore nipponico dà grandi soddisfazioni. Ha ormai da anni una supremazia sugli ovali innegabile (la scorsa 500 Indy i motorizzati Honda avevano una marcia in più rispetto agli Chevy) e pare sia riuscita a bilanciare meglio il suo pacchetto aerodinamico, che negli ultimi tre anni ha sempre pagato qualcosa nei confronti della Casa col Cravattino. Il 2017 è l’anno giusto per provare il colpaccio. Lo hanno capito a Tokyo, a Woking e a Oviedo.
Il tris di carte è buono: pilota dal talento cristallino, team con le ossa solide (e la stampella di un supporto McLaren), pacchetto tecnologico all’altezza. Sarà una sfida difficile. Ma vediamo come va questa mano, e parliamo solo alla fine.
Foto 3 e 4 da https://petece.imgur.com/